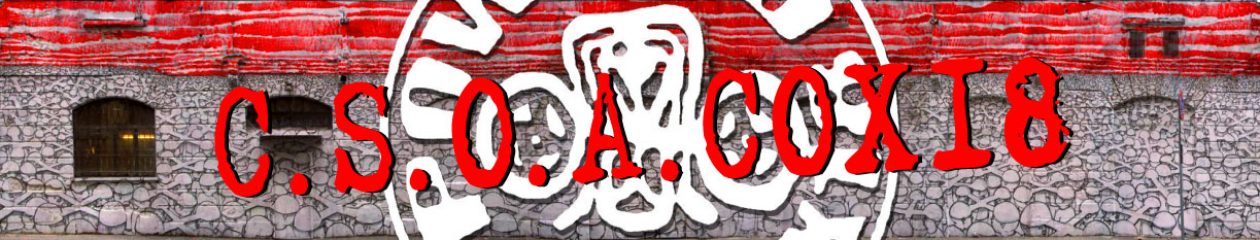Di questi tempi si fa un gran parlare di Milano.
Vale la pena di ricapitolare per sommi capi i termini della questione.
Da un lato vi è la presa d’atto, utile ancorché tardiva, di quanto e come si sia trasformata la sua scorza nell’ultima ventina d’anni. L’anima era mutata da ancor prima, la progressiva chiusura degli stabilimenti industriali lasciava spazio alla precarietà sociale e a grandi aree dismesse in attesa di ricollocazione. Non fu difficile per una giunta rampante assecondare i desiderata di ‘colleghi’, immobiliaristi e prendere a giocare forsennatamente al cubo di Rubik cominciando con lo spostare la Fiera Campionaria a Pero, per poi edificare CityLife e arrivare infine a quell’apoteosi del non-luogo denominata ‘piazza’ Gae Aulenti, non senza essere passati attraverso quella desolante radura nota come ‘Biblioteca degli Alberi’.
Inutile dire che poca o nessuna cura fu riservata agli espulsi dal ciclo produttivo a seguito della chiusura (o delocalizzazione) degli impianti industriali e quasi nessuna tutela fu attivata per chi, ancor peggio in arnese, arrivava a Milano per sfuggire a guerra e fame o in cerca di fortuna. I servizi sociali soffrivano l’incontrastata invadenza dell’ideologia privatistica, nascosta sotto la foglia di fico dei vincoli imposti dalla crisi economica, con la sanità “universale” a fare da vittima prediletta. Intanto il prezzo degli affitti saliva. Università prestigiose, direzioni aziendali di rinomati marchi, dall’abbigliamento al mobile, affaristi di diverso genere, attiravano una popolazione più solvente che disposta a essere residente. Questa casa è un albergo.
Anche per questo il processo di gentrificazione premeva sulle fasce sociali deboli e le spingeva ‘più in là’. Chi aveva una casa lontana forse ha preferito tornarci mentre gli altri si allontanavano dai quartieri che si stavano “rigenerando”. Poi fu sfornata una nuova panzana, la Città Metropolitana, e tanto bastò agli ignavi: una edilizia popolare a Milano non c’era più, ma alcuni alloggi più a buon mercato si potevano trovare nella cerchia dei comuni dell’hinterland, gli spazi comunali del centro erano messi a valore e il sociale si spostava nelle periferie, vero, ma sarebbe potuto andare ancor peggio. La saggezza popolare, per quel che può valere, l’aveva già detto: non c’è peggior cieco di chi non vuol vedere…
Dati del Comune dicono che meno del 40% degli attuali residenti del Comune di Milano, lo era anche 15 anni fa[1]. Una trasfusione di sangue della popolazione residente che fa impressione.
Da città produttrice di merci industriali, Milano è diventata città della speculazione immobiliare, del design, del lusso, dell’affare e del malaffare, e, incredibilmente, una attrazione turistica.
Quindi, mentre i grattacieli si avvitavano sempre più in alto – ma occhio alle insegne soprastanti, meglio non starci sotto… -, quanto restava dell’edilizia popolare andava in malora sotto gli occhi di tutti, gli appartamenti si svuotavano e venivano chiusi e blindati con lastre d’acciaio. Uno schiaffo alla miseria e al buon senso (oltre che un cattivo uso di un patrimonio pagato dalle trattenute sulle buste paga dei lavoratori dipendenti).
Di questi tempi si fa un gran parlare di Milano. Del miracolo economico, un modello esemplare per il Paese, come sosteneva l’alleanza bipartisan tra Pd, +Europa, Italia viva e Azione, insieme con tutto il centrodestra per approvare la legge “Salva Milano” (che evoca beffardamente i giochi di parole della “Settimana Enigmistica”) allo scopo di sistemare alcuni trascurabili incidenti di percorso. Un miracolo che non si faceva mancare il supporto dell’associazionismo, il terzo settore, sussidiari delle scelte del governo della città e spesso cinghia di trasmissione della trasformazione. La chiamavano Milano arancione.
Di come siamo combinati oggi si parla fin troppo. Più interessante, a questo punto, diventa mettere in relazione questo processo di ristrutturazione, che non riguarda in esclusiva Milano, s’intende, con una tendenza più generale in atto nei Paesi a economia capitalistica più avanzata. Di fatto il modello di crescita del valore attraverso la produzione e lo scambio di merci si è inceppato con un conseguente spostamento degli investimenti sulla rendita (il mercato immobiliare, il turismo, le spiagge privatizzate, …) o sulla finanza (il debito e il suo commercio). Ai ‘peones’ resta solo la possibilità di aprire un mutuo, per andare a scuola, per curarsi, per pagarsi la casa o il lusso di una vacanza. A livello nazionale, poi, un “testo unico sulla sicurezza”[2] garantisce strumenti di controllo sempre più estesi e drastici.
Giocoforza occorreva attivare strumenti di contenimento del dissenso e del disagio, e le politiche nazionali offrivano già un vasto repertorio: retorica della legalità (da applicarsi, ovviamente, solo nei confronti dei poveri), politiche contro gl’immigrati (CIE, CPR, respingimenti), sfratti delle famiglie bisognose o “irregolari”, zone “rosse” a sorveglianza speciale, che istituiscono divieti di accesso a parti della città senza bisogno di istruttoria, dibattimento, senza possibile ricorso.
Si tratta di un ancor più generale processo di restrizione delle libertà collettive e individuali in nome della necessità, ogni volta descritta come “temporanea”, di affrontare l’emergere di un pericolo “estraneo” ad un corpo sociale che viene definito “sano”. A tale fenomeno l’Italia assiste almeno da quando fu invocata l’“emergenza terrorismo rosso”, seguita dall’“emergenza mafia”, dall’“emergenza terrorismo islamico” (benché in Italia non ci sia stato mai neanche un solo attentato “islamista”), dall’“emergenza immigrati”, dall’emergenza Covid e infine (last but not least) dal rischio imminente di una invasione russa [sic!]. Pensiamo, per i tempi più recenti, a quel che fu l’introduzione di un lasciapassare per accedere ai locali (e mezzi di trasporto) pubblici o al reato penale, istituito in molti Paesi, di criticare la politica bellicista di uno Stato estero genocidiario.
Allo scopo di restringere gli ambiti di agibilità collettivi molto servono le nuove tecnologie, capaci di generare un’apparenza di socialità in un contesto reale di totale solitudine. Molto fanno i sistemi di controllo che seguono ogni istante della giornata, ma molto fa anche il muscolare attacco a tutte le istanze che continuano a manifestare il dissenso e l’obiezione politico-culturale: meglio del questurino non è stato inventato ancora nulla. Le pratiche d’autodeterminazione, quale che ne siano il profilo e la traiettoria, costituiscono un pericoloso esempio di gestione orizzontale dei bisogni: lì potrebbe annidarsi il germe della rivolta, meglio estirpare.
Qui si concentra l’azione dello Stato la cui più recente (ma non ultima) trovata è il Decreto Sicurezza 2025[3].
Una parola, quindi, andrebbe spesa sul concetto di “legalità” che gode di una reverenza bipartisan (anche qui) e che fa dire: ciò che è legale va bene e ciò che è illegale no. La legalità, oltre a essere il baluardo della proprietà privata[4], si piega sempre di più alle esigenze dell’agenda di governo, che norma a botte di decreti d’urgenza. E sia detto una volta per tutte: il vero nemico è il bipartisan.
Per tornare a Milano, illegale è occupare un appartamento di edilizia popolare chiuso da anni mentre non lo è lasciare chiusi e inutilizzati per anni migliaia di appartamenti di questo tipo. Illegale è cercare rifugio rischiando la propria vita mentre non lo è omettere il soccorso e lasciar morire chi ne ha bisogno. Legale è inseguire a sirene spiegate due ragazzi in scooter per la città purché non li si speroni. Che poi il motorino esca di strada, e uno dei ragazzi muoia è uno spiacevole incidente. Come illegale fu manifestare contro il G8, ma non lo fu menare i manifestanti a sangue e costringerli a cantare Faccetta nera dopo l’arresto.
La “legalità” è una bestia strana. L’anarchico Alfredo Cospito nel 1991 fece uno sciopero della fame perché ingiustamente condannato per una seconda volta per diserzione alla leva. La Corte Costituzionale gli dètte ragione e lo riconobbe vittima di una legge sbagliata. Nel 2022 lo stesso Cospito inizia, contro l’ergastolo e il regime del 41 bis, un secondo sciopero della fame che durerà 181 giorni al seguito del quale la Corte Costituzionale dichiarerà incostituzionale il “divieto di prevalenza di tutte le attenuanti, nei confronti della recidiva reiterata, per tutti i reati la cui pena edittale sia fissa e contempli il solo ergastolo”[5]. Questo è un caso, forse unico, di legalità “raddrizzata” due volte dalla testardaggine di una medesima persona, che per altro a questa legalità non crede.
Scherzi a parte, in Italia è legale, attraverso un provvedimento amministrativo (e quindi senza passare per una sentenza di tribunale), consegnare un essere umano a una detenzione spietata come il 41 bis e tenercelo per anni e anni, fino alla morte.
Per finire tornando a Rubik e al suo cubo, non sappiamo se ristrutturare un magazzino facendone un grattacielo sia una pratica che un tribunale sanzionerà come illegale. Di sicuro trasformare una città in un residence per ricchi fa schifo. E tanto ci basta.
~*~
In questo processo di attacco alle libertà collettive si inquadra l’annosa polemica contro i Centri Sociali. Non è possibile qui ripercorrere la storia politica (lunga, differenziata e financo contraddittoria) di questi luoghi, che nacquero come espressione di giovani proletari (allora si diceva così) intenzionati a difendersi da un quotidiano fatto di emarginazione ed eroina. Molti sono i testi in proposito e invitiamo gli eventuali interessati a leggerne qualcuno[6].
Osserviamo qui solo che questi luoghi, per la loro natura, permettono ai frequentatori di organizzare attività culturali e politiche libere dai vincoli del mercato. Il loro principio è l’autogestione ossia un’organizzazione demandata a una assemblea che, come direbbe Franti, “qualora vi sia bandita la ‘lingua di legno’, attraverso le parole, prosegue quel moto di incontro che ha portato i partecipanti a riunirsi”[7].
I Centri Sociali, ciascuno a modo suo, sono stati testimoni diretti dell’evoluzione della città e, molto prima che ciò divenisse oggetto di discorso pubblico, ne hanno registrato e vissuto le trasformazioni sia della scorza sia dell’anima. Qualcuno ha seguito e descritto con meticolosa attenzione e molto tempismo queste vicende[8], qualcun altro vi ha dedicato riflessioni estemporanee ma ficcanti[9], tutti comunque ne sono stati investiti e hanno cercato di reagirvi.
Testimoni scomodi e portatori di un dissenso un filino eccessivo, manifestano un’attitudine comunque poco gradita dagli amministratori. L’autonomia e la controcultura continuano a scocciare.
Per altri versi, questo va riconosciuto, alla città fan comodo. Ne contengono parte del disagio sociale offrendo occasioni di incontro e di sfogo a prezzi calmierati tamponando, in parte, il suo malessere. Inoltre offrono ai quotidiani l’opportunità, almeno una volta all’anno, specie d’estate, di fare il paginone con la mappa cittadina dei luoghi di aggregazione, coi numerini e tutte le varie gradazioni del flavour “antagonista”.
Se il gioco del mattone è un must bipartisan almeno dall’anno 2000, e costituisce il vero cuore della politica, l’atteggiamento verso i Centri Sociali può rappresentare un terreno divisivo. Vi sono esempi recenti di amministrazioni della c.d. Sinistra che hanno saputo riconoscere queste esperienze e rispettarne l’autonomia e la storia[10] mentre la Destra, ancorché di governo, è in generale più sbrigativa e mantiene la sua tradizionale avversione per le zecche rosse.
Lo sgombero dei centri sociali è per la Destra più di una piattaforma elettorale, è un’ossessione. E nella sua reazione aggressiva le capita di evocare, seppure a contrario, molti dei punti cruciali del vivere urbano: la mancanza di alloggi, l’obbligo al lavoro, il poliziotto come baluardo dell’ordine (in ciò la Destra è più realistica della c.d. Sinistra). Su questo terreno, nella dialettica delle parti, può accadere di vedere il governo centrale scavalcare i governi locali e intervenire con tutti e quattro gli arti tesi (secondo una postura di moda su entrambe le sponde dell’Atlantico). è un modo di giocare al potere. Di regola il governo locale abbozza e risponde lamentando, al massimo, di non essere stato neanche avvisato. Un po’ più di spina dorsale, che diamine!
Sappiamo che oggi i giovani proletari (o sottoproletari) sono altrove, spinti “più in là”, appunto; da loro s’ha da aspettarsi qualcosa di nuovo, perciò: occhi aperti e orecchie tese. Luoghi di aggregazione, infatti, ne restano sempre meno, vuoi per le chiusure forzate vuoi per il venir meno delle assemblee di gestione, causa limiti di età. Dar vita a nuove aggregazioni a partire dall’occupazione di un luogo fisico è diventato ancora più difficile, non perché ne manchino la necessità e la voglia ma perché la risposta repressiva pare non lasciare il tempo di consolidare la nuova esperienza. La Polizia, già Celere, è diventata Fulminea. Il fiato delle nuove occupazioni è perciò terribilmente corto (tanto per gli spazi sociali quanto per l’abitativo), ma restano comunque evidenti le preoccupazioni che questa pratica genera ai piani alti.
Anche se la cosa ruga alla Destra, l’Italia ha conosciuto lungo tutto il Novecento (anche prima e anche dopo) una persistenza di lotte popolari e proletarie che ha pochi eguali a livello internazionale. Milano è stata a lungo una città simbolo di questa persistenza, e i suoi centri sociali ne hanno costituito una piccola ma significativa componente. Nati una cinquantina d’anni fa, accade così che i Centri Sociali sopravvissuti si facciano Archivio (nel senso pieno della parola), ossia che conservino, tutelino, sistemino e mettano a disposizione della collettività (gratuitamente ça va sans dire) diversi elementi utili alla conoscenza delle culture e degli usi della città. Di ciò, però, sarete già stati informati.
Che poi tutto questo gran parlare di Milano abbia a che fare con le imminenti elezioni è cosa ben possibile ma che non ci tocca[11].
C’è una conclusione a queste nostre righe? Se c’è, sta in quell’urgenza che spinge a esserci e ad affrontare le contraddizioni.
Milano, inizi di settembre dell’anno 2025
Cox18, Calusca City Lights, Archivio Primo Moroni
1. Comune di Milano: Una nuova strategia per la casa. https://www.comune.milano.it/documents/20126/2037838/003-DELC-58-2023-All_2-Una_nuova_strategia_per_la_casa_All2.pdf ↩
2. Un “testo unico” sulla “sicurezza” lungo quarant’anni (1974-2013). Questo sunto si ferma al 2013 ma i provvedimenti si sono susseguiti anche dopo. Fino a oggi. https://www.inventati.org/cope/wp/testo-unico-1974-2013/ ↩
3. DECRETO-LEGGE 11 aprile 2025, n. 48. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/04/11/25G00060/sg. ↩
4. Per chi è incuriosito dall’argomento potrebbe essere utile consultare il materiale del ciclo Le lunghe ombre del diritto, organizzato nel 2011 dall’Archivio Primo Moroni e dal Centro Donato Renna. https://www.inventati.org/apm/penale/. ↩
5. Pensare l&impensabile, tentare l’impossibile. A fianco di Alfredo contro l’ergastolo e il 41 bis, a cura di Archivio Primo Moroni, Calusca City Lights, CSOA Cox 18, Colibrì, Milano, 2023.. ↩
6. Elenco sommario di testi a stampa ordinati in senso cronologico. https://www.inventati.org/apm/materiali/bibliografie/bibliografiaCS.pdf ↩
7. Trattatello di anatomia ergonomico-funzionale contemporanea, a cura di Franti, Colibrì, Milano, 2017. ↩
8. Uno per tutti, a Milano, il collettivo Off-Topic. https://www.offtopiclab.org/pieghevole/ ↩
9. EXPO 2015 – le mani sulla città. https://www.inventati.org/apm/index.php?step=expo2015 ↩
10. Livio Pepino, C’era una volta il Leoncavallo. https://volerelaluna.it/in-primo-piano/2025/08/25/cera-una-volta-il-leoncavallo/ ↩
11. … e la chiamano estate … https://www.inventati.org/apm/index.php?step=estate [e scaricate la versione in PDF, che è più bella]. ↩